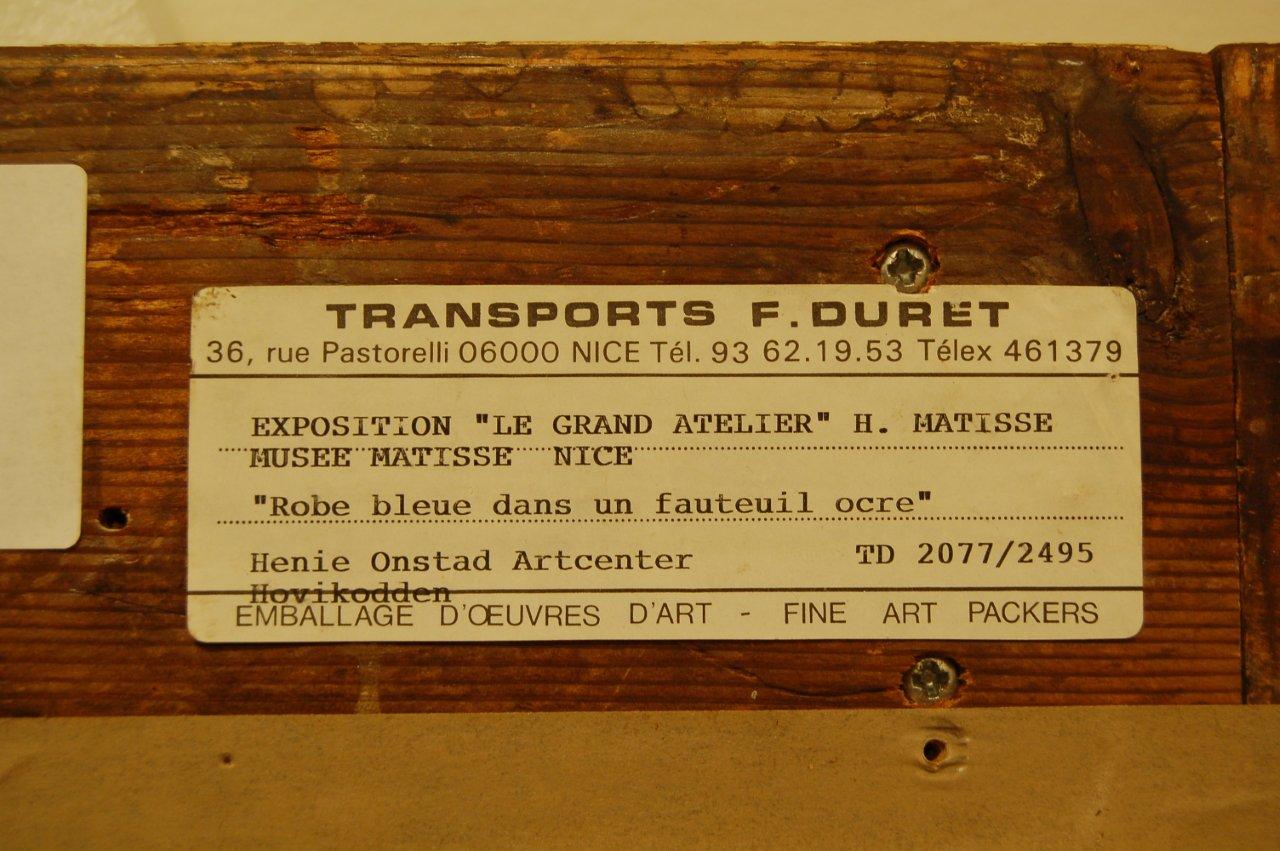“Quanti Jan Fabre esistono?
Soffro forse di schizofrenia?
Parlo con tutti quanti loro,
qualche volta persino ad alta voce.
Nel mio atelier,
per Strada.
O forse sto semplicemente interrogando me stesso?”
Era il 7 giugno 1979 quando Jan Fabre scriveva queste righe nel suo primo Giornale Notturno. Un documento che all’epoca doveva apparire come la versione confusa di una ricerca improbabile, e che oggi, invece, a distanza di quarant’anni, sembra costituire la genesi di una ricerca.
Una città – Venezia – e un luogo – l’Abbazia di San Gregorio, appena un attimo prima della Basilica di Santa Maria della Salute – sono la realtà entro la quale Fabre ripercorre questi quarant’anni e alcuni aspetti della sua esperienza artistica attraverso un sottilissimo e persistente fil rouge, rintracciabile a stretto giro nei pochi – tre – materiali adoperati, e più ampiamente nei suoi temi ricorrenti, che divengono la sua primaria necessità.
Glass and bone Sculptures 1977-2017 è uno degli eventi collaterali della 57esima Biennale di Venezia, e già nel titolo riassume tutta la sua essenzialità.
Restando in superficie, si rischia di percepire qualcosa di insensato che valica i confini del politicamente corretto per addentrarsi nel terreno scivoloso dell’offesa, dello spregio e della follia. E invece, se si sceglie di guardare più a fondo, di leggere tra quei piccoli pezzi di ossa tenuti insieme in maniera meticolosa, di approfondire quel materiale diafano reso fosco dall’inchiostro, ne viene fuori una iniziazione, che conduce il proprio sé alla concretezza della morte, con un atteggiamento rituale e sacrale.
L’inchiostro della BIC di un blu che compenetra nel viola dalle sfumature metalliche; il vetro (anche di Murano), fragilissimo all’impatto eppure il più resistente sul piano corrosivo; e le ossa, il più delle volte umane, che invece si riducono relativamente presto in polvere. Questi gli elementi cardine che smettono di essere un mezzo in sé per diventare il medium eloquente, traccia tangibile di una dimensione umana che ne evoca una spirituale.
Vetro e ossa che celebrano l’inizio e la fine della vita come se fossero due punti indeterminati di un ciclo dal raggio immisurabile, e una resa così palpabile da porre il visitatore davanti alla propria, intima riflessione corporale e mistica.
Del resto, sono sempre gli altri che muoiono, si è portati a pensare (come nell’ultimo paradosso dadaista e duchampiano), e invece Jan Fabre ci pone davanti ad una dimensione tutta individuale, dove ognuno traspone nelle opere, ma soprattutto nel materiale utilizzato, la caducità e la fragilità della propria esistenza.
“Vincerò la mia battaglia contro il tempo, quando questo non avrà più importanza”, scriveva ancora.
Il Tempo. Quella continuità che divora la memoria, diventa il perno su cui ruotare per guardare invece alla ciclicità. E “da un’altra faccia del tempo” è anche la scritta che si staglia lungo il muro di un grande ambiente, insieme ad una suggestiva canoa assemblata con ossa umane e animali, in una visione meticolosa e ordinata di una fossa comune dalle identità perse nella privazione di una fisionomia.
Un arco narrativo aperiodico, che vede nella genesi un punto indistinto della circolarità della vita, dal quale comunque partire e ripartire, come nel Planet I-IX dove nove sfere poste in sequenza sembrano un calendario lunare in perenne fecondazione.
E cosa sono quelle forme di ossa se non l’allusione che ogni corpo abitato temporaneamente null’altro è che un vestito del quale ci si disfa in un tempo relativamente breve?
O ancora, The Catacombs of the Dead Street Dogs. Una stanza che sembra contenere i resti di un party, e invece ne trattiene le tracce, svuotate inesorabilmente della vita in una scena rovinosa dove gli scheletri dei cani randagi riportano alla mente Il Natale dei rimasti di Angelo Morbelli (un quadro divisionista altrettanto potente dove i rimasti, appunto, sono degli uomini che della vita non sentono neanche più la percezione fisiologica e i corpi altro non sono che degli involucri in attesa del trapasso).
E poi, sconnessi dalla successione di questo racconto, teschi blu assemblati a scheletri di uccelli, scoiattoli e ratti; cumuli di ossa in vetro sormontati da piccole sculture di organi sessuali; un ciucciotto dal sapore sarcasticamente dadaista; e una sala con un intestino sospeso e le sculture di un altro teschio e una tartaruga circondate da piccole sfere trasparenti e blu, in un’opera ambiente tutta da attraversare e da vivere.
Per ultimo (e per primo), la metamorfosi di uno scarabeo verde occupa il centro di quel chiostro in pietra d’Istria, mentre il tipico esemplare faunistico veneziano spadroneggia sulle travi che corrono tutt’attorno. Usciamo da un luogo che sembra essersi trasformato in ossa, anche lui.
Usciamo nuovi, da una mostra altissima che, parafrasando lo stesso Jan Fabre, rischia di sfuggire alla coscienza umana per l’incredulità.
—
Grazie al team di sorveglianza dell’esposizione e alla preziosissima Cecilia Foresi, per le lunghe conversazioni su Fabre e non solo.
La mostra è curata da Giacinto di Pietrantonio, Katerina Koskina, Dimitri Ozerkov, promossa da GAMeC-Bergamo e visitabile gratuitamente fino al 26 novembre prossimo.
—
Consigli di lettura.
Giornale notturno I (1978-1984) e Giornale notturno II (1985-1991), Jan Fabre, Edizioni Cronopio, 2013.
Vista con granello di sabbia, Wisława Szymborska, Adelphi 2009
Solo bagaglio a mano, di Gabriele Romagnoli, Feltrinelli, 2015.